Quante volte ci siamo sentiti impotenti e sconfitti quando apprendiamo l’ennesima notizia di un giovane che si è suicidato, e magari c’entra la droga? Oppure quando i media ci servono, per colazione e per cena, numeri sempre più allarmanti sul disagio giovanile? Anzi, oggi la parola che si usa per definire la Gen Z, più che “disagio”, è “fragilità”. Pensa allora a quanta frustrazione prova chi ogni giorno convive con un familiare che soffre di una dipendenza. Da sostanza (come droghe o alcol) o comportamentale (come il gioco d’azzardo), non fa molta differenza.
Tutti noi apparteniamo a quel contesto sociale che deve dare risposte e soluzioni a problemi sempre più diffusi, come le addiction fra i giovani. Tutti, insieme alle istituzioni, ai professionisti e alle associazioni. Lo sa molto bene — ma soprattutto lo sa spiegare e mettere in pratica — Gabriele Zanardi, psicologo, psicoterapeuta e docente presso l’Università degli Studi di Pavia. Coordina progetti di prevenzione per il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri; collabora inoltre con l’Istituto Superiore di Sanità per la formazione e l’informazione sulle dipendenze patologiche comportamentali, compreso il gioco d’azzardo. Dal 2020 è presidente della Società Italiana Tossicodipendenze, sezione Lombardia.
Quello che Gabriele Zanardi ci propone è la costruzione e il mantenimento di una rete integrata di risorse fatta di: persone singole, scuola, famiglia e servizi pubblici che devono collaborare per costruire progetti di prevenzione e cura. Questa soluzione la chiama connettoma che nel linguaggio scientifico è la mappa completa delle connessioni neuronali nel cervello.
È un termine che deriva dall’unione di “connessione” e “genoma”, coniato per indicare l’insieme delle reti di neuroni e delle sinapsi che collegano le varie aree cerebrali — un po’ come una mappa stradale del nostro sistema nervoso. Una rete di supporto a quella che non chiameremo più fragilità (che è una condizione patologica), bensì vulnerabilità, ossia uno stato esistenziale. In questa rete umana ha anche spazio la tecnologia, a servizio della sensibilizzazione.
Cosa intende nello specifico per connettoma?
Oggi nella nostra società ci sono ancora diversi nuclei che, seppur funzionanti, non collaborano, perché rimangono arroccati sulle loro posizioni. Ho perciò preso in prestito un termine scientifico, perché il cervello è un organo di relazione che elabora informazioni come un complesso sistema di linee della metropolitana. I neuroni sono le vie su cui viaggiano i vagoni — le informazioni — connesse tra loro. Succede che, quando attuiamo e ripetiamo determinati comportamenti, avvengono modifiche biologiche. Questo per dare l’idea della potenza del nostro cervello, e dunque di come questo processo di straordinaria contaminazione che ci appartiene biologicamente possiamo trasferirlo metaforicamente nel potenziare le reti sociali.
Infatti, così come il nostro cervello, quando deve produrre un risultato, attiva distretti diversi che per funzionare devono comunicare tra loro, così deve fare la società. Il cervello è il modello per una funzionalità metodologica vincente. I singoli elementi, se non sono messi in rete, perdono la loro potenzialità. Inoltre, se sono connessi, quando un elemento non funziona, un altro può sopperire. Un sistema sociale così concepito, esattamente come il cervello, è in grado di modificarsi in base all’ambiente e di anticipare ipotesi per la soluzione di eventuali problemi.
Ci fa un esempio di come la rete si inceppa?
Se un ragazzo di 15 anni vive in una famiglia dove abitualmente si gioca al Lotto, non si pone grossi problemi a passare alle scommesse sportive. E se questo “gioco” diventa una malattia, la famiglia, la scuola e la psicologa della scuola devono collaborare per indirizzare il ragazzo nel luogo giusto, dove cominciare un percorso di cura — per esempio spiegandogli che il Ser.D non è “il posto dei tossici”, ma un luogo di cura per tutte le dipendenze, anche quella da azzardo.
Serve dunque anche un cambiamento di linguaggio?
Certamente. È fondamentale comunicare correttamente, altrimenti, per esempio, il signore anziano al Ser.D non ci va, perché lì “ci sono i tossici”. E poi non serve criticare i singoli nodi del sistema, che devono mantenere la loro autonomia. Serve invece imparare a comunicare in modo funzionale. Perché se non sono messi in rete, i nodi perdono la loro potenzialità.
In questo contesto cosa può fare il singolo, tutti noi che apparteniamo alla società civile?
Prima di tutto: l’allerta precoce. Non dobbiamo sottovalutare o minimizzare i segnali di vulnerabilità. “Mah sì, è soltanto una cannetta, cosa vuoi che faccia”, oppure “Un gratta e vinci ogni tanto non è azzardo”.
Senza allarmismi o proibizionismi — che tanto non servono — ma con consapevolezza. E la consapevolezza si acquisisce con la conoscenza.
Per esempio, studi su persone tossicodipendenti in comunità hanno evidenziato che il 98% di loro ha iniziato con la cannabis, mentre il 24% di chi ha fatto uso di cannabis è diventato tossicodipendente. Questi risultati non dimostrano ancora una correlazione diretta, eppure qualcosa ci dicono. Così come le bevande a basso contenuto alcolico che bevono molti adolescenti abituano i quindicenni a quella sensazione di euforia e leggerezza che, quando compiono 18 anni, cercano nello spritz. Si chiama reward dopaminergico: è quel piacere che ti ha agganciato e che, per rimanere nell’esempio dell’alcol, ti fa passare presto ai superalcolici. Certo, non accade a tutti, ma è comunque una pratica che prepara il nostro cervello. E quindi, se poi accade un fatto doloroso o destabilizzante (mi lascia la fidanzata, non passo l’esame universitario, mi licenziano…), può tornarmi in mente quella nota di piacere, come una carezza che consola. E allora la cerco.
Quando questo accade — anche prima che diventi patologico — è fondamentale rivolgersi ai centri specializzati. Non aspettare e non sottovalutare. Meglio un falso positivo che arrivare quando si è già caduti nella dipendenza. Tutti abbiamo delle vulnerabilità: un disequilibrio del nostro vissuto che ha riflessi anche biologici e ci porta a cercare gratificazione — come per esempio sperare in una grande vincita al Lotto, alle slot machine o con i gratta e vinci. Quindi tutti siamo potenzialmente a rischio. Ecco allora che la consapevolezza e l’attenzione sono importanti. Ovviamente, insieme è meglio. Per tutti.
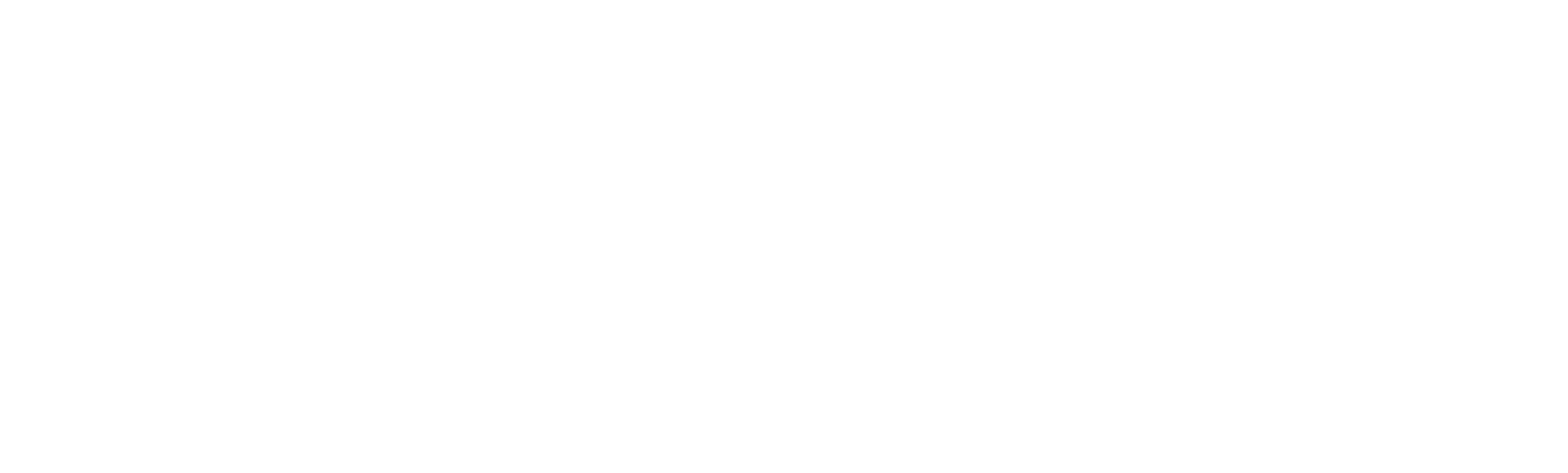
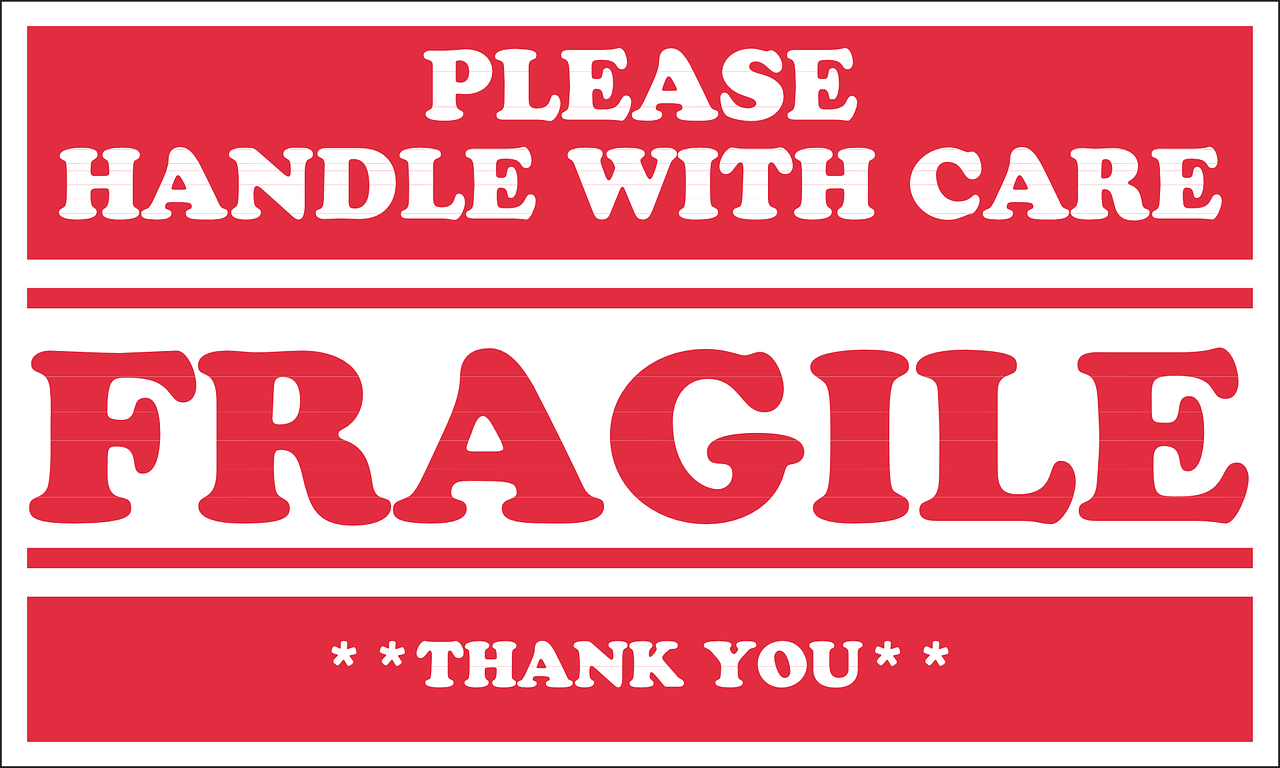
0 commenti