Accorgersi che una persona cara ha un problema con il gioco d’azzardo è doloroso e destabilizzante. All’inizio spesso prevalgono dubbi e sospetti: “Sta davvero giocando troppo? È solo un passatempo o c’è qualcosa di più grave?”. Quando poi la situazione diventa evidente, il passo successivo è chiedersi: Come parlarne senza litigare, senza essere respinti o senza peggiorare le cose?
Il silenzio, però, non aiuta. La dipendenza da gioco è una vera e propria patologia comportamentale, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e affrontarla tempestivamente può fare la differenza. Ma non basta dire “smetti di giocare”: serve un approccio diverso, più delicato ed efficace.
La psicologa Elena Colombo, ospite del podcast Se questo è un gioco, ha condiviso tre consigli fondamentali che ogni familiare può adottare per aprire un dialogo con chi gioca in modo problematico. Sono strategie semplici ma potenti, che aiutano a costruire un ponte comunicativo invece che un muro di conflitti.
Primo consiglio: insinuare il dubbio con delicatezza
Il primo passo è non accusare direttamente. Dire frasi come “Tu sei malato” o “Sei un giocatore compulsivo” rischia solo di provocare difese, rabbia e negazione. Chi ha una dipendenza spesso non è pronto ad ammetterlo, e sentirsi attaccato non fa che rafforzare il rifiuto del problema.
Il consiglio della psicologa è invece di insinuare un dubbio. Come farlo? Con domande aperte e osservazioni neutre, che invitino a riflettere: “Hai notato che ultimamente passi molto tempo al gioco?”, “Ti sembra che ti stia creando più preoccupazioni che divertimento?”, “Pensi che questa situazione stia influenzando anche altri aspetti della tua vita?”. Si tratta di piccoli semi di consapevolezza, che non obbligano a risposte immediate ma aiutano la persona a iniziare a guardarsi dentro.
Perché funziona
Perché non parte da un’accusa, ma da una riflessione condivisa. Invece di puntare il dito, si apre una finestra che permette al giocatore di mettersi in discussione senza sentirsi schiacciato dal giudizio.
Secondo consiglio: aumentare la percezione dei rischi
Molti giocatori patologici hanno credenze distorte: pensano che dopo tante perdite arriverà la vincita, che aumentando le giocate aumentino le probabilità di successo, o che la “quasi vincita” sia un segnale che la fortuna sta per girare. Queste illusioni alimentano il comportamento compulsivo.
Il familiare può intervenire portando informazioni dall’esterno, senza mettersi in cattedra: “Ho letto che i giochi sono programmati per far vincere sempre il banco…”, “Sai che in Italia l’azzardo viene definito una tassa sulla povertà?”, “Ho sentito un esperto dire che le probabilità di vincere sono molto più basse di quello che pensiamo.” Non si tratta di fare una lezione, ma di aumentare la percezione dei rischi con spunti semplici e indiretti.
Perché funziona
Perché introduce un dubbio cognitivo: se fino a ieri il giocatore era convinto di poter “battere il sistema”, ora deve fare i conti con informazioni che mettono in crisi quella certezza. È un modo per stimolare la consapevolezza senza scontro frontale.
Terzo consiglio: parlare degli effetti su di sé
Uno degli errori più comuni dei familiari è accusare direttamente: “Tu rovini la famiglia”, “Per colpa tua non arriviamo a fine mese”, “Sei egoista”. Anche se possono sembrare affermazioni comprensibili, in realtà chiudono la comunicazione. La psicologa consiglia invece di parlare in prima persona, spostando l’attenzione sugli effetti che il comportamento del giocatore ha sugli altri, senza colpevolizzare: “Io mi sento molto preoccupata quando spendi tanto al gioco”, “Mi fa stare male vedere che ti isoli”, “Mi sento ansioso quando non so dove sei o come stai usando i soldi”. Questo approccio permette di comunicare emozioni autentiche senza trasformarle in un attacco.
Perché funziona
Perché chi ascolta non si sente accusato, ma percepisce l’impatto reale delle proprie azioni sulle persone care. È un modo più empatico per dire: “Il tuo problema non è solo tuo, ma ci tocca tutti.”
Errori da evitare quando si parla con chi gioca
Oltre ai tre consigli, è importante sottolineare alcuni atteggiamenti che rischiano di peggiorare la situazione:
- Evitare minacce (“Se non smetti ti lascio”): alimentano solo paura e conflitto.
- Evitare promesse impossibili (“Ti prometto che cambierai”): nessuno può garantire l’uscita immediata da una dipendenza.
- Non sostituirsi completamente al giocatore: gestire tutto al posto suo (debiti, conti, problemi) può rinforzare la dipendenza.
Il ruolo dei familiari: sostenere senza farsi schiacciare
Un familiare non può “salvare” da solo una persona con dipendenza da gioco. Il rischio è di cadere nella co-dipendenza, caricandosi di tutto e consumando le proprie energie. L’obiettivo è stare accanto, con fermezza e affetto, ma anche con la consapevolezza dei propri limiti. Significa:
- proteggere le finanze familiari;
- non coprire le bugie o i debiti;
- cercare alleanze con altri membri della famiglia;
- rivolgersi a professionisti per avere supporto.
Quando chiedere aiuto esterno
Se il dialogo non basta, non bisogna sentirsi in colpa: la dipendenza da gioco è una malattia che richiede competenze professionali. In Italia esistono servizi gratuiti a disposizione:
- i SerD (Servizi per le Dipendenze) territoriali;
- gruppi di auto-aiuto per giocatori e familiari;
- associazioni specializzate come Vinciamo il gioco con cui un sevizio di supporto gratuito online grazie ai fondi dell’8×1000 alla Chiesa Avventista.
Parlare con un familiare che ha un problema di gioco d’azzardo è difficile, ma possibile. I tre consigli della psicologa Elena Colombo – insinuare il dubbio, aumentare la percezione dei rischi, parlare degli effetti personali – sono strumenti semplici, ma concreti per aprire la strada a un confronto. Se in famiglia stai affrontando una situazione simile, ricorda: non sei solo. Con il supporto giusto, il silenzio e la paura possono lasciare spazio al dialogo e al cambiamento.
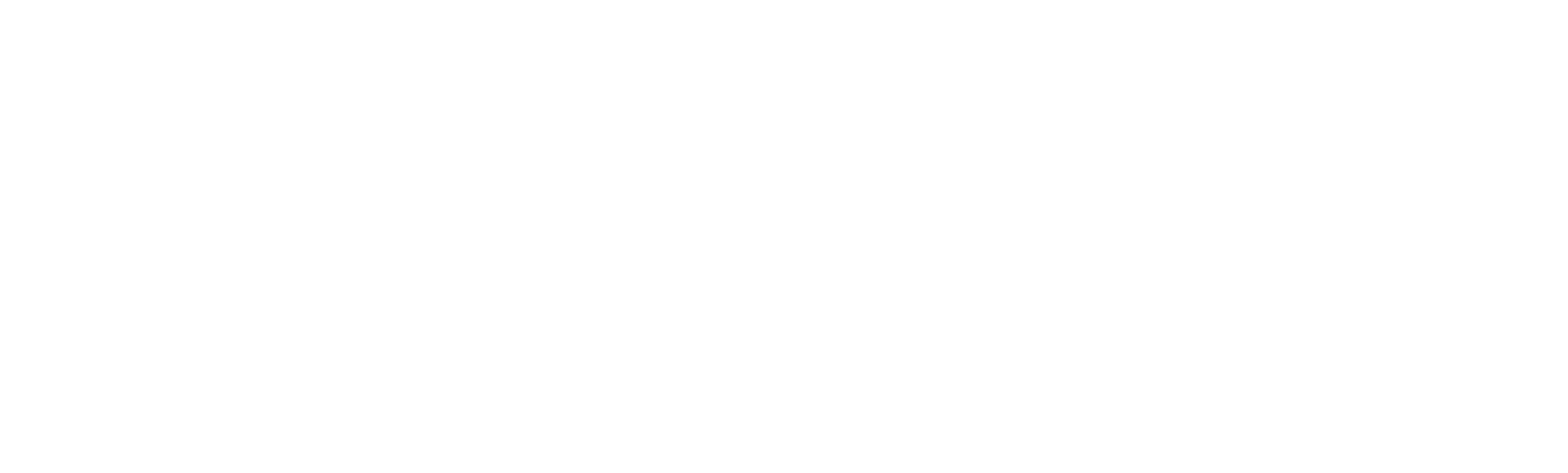

0 commenti