Il senso di vergogna e lo stigma sociale che circondano il gioco d’azzardo, sia per chi gioca sia per i familiari, spesso impediscono di chiedere aiuto e possono aggravare la situazione. La difficoltà di ammettere la dipendenza e la paura del giudizio altrui possono portare all’isolamento e al peggioramento del problema.
C’è una frase che molte persone che vivono l’esperienza della dipendenza da gioco d’azzardo pronunciano, prima o poi: “Mi vergognavo troppo per parlarne.” Non è solo una sensazione individuale. È un effetto sistemico, sociale, collettivo. È la conseguenza diretta dello stigma che rende estremamente difficile fare il primo passo verso la cura: chiedere aiuto.
Questo stigma colpisce chi gioca in modo compulsivo, ma anche le famiglie e contribuisce in modo concreto all’aggravarsi del problema, rendendo invisibili le persone che ne soffrono, ostacolando l’accesso alle cure, rinforzando la solitudine, la colpa, il silenzio.
Quando il giudizio e la vergogna paralizzano
La dipendenza da gioco non si vede. Non ha segni esteriori immediatamente riconoscibili. Non provoca sintomi fisici evidenti come altre dipendenze. Eppure, dentro, il dolore c’è. Ma spesso non trova parole per venire espresso, e questo è uno dei drammi più diffusi e trascurati.
Chi soffre di dipendenza da gioco d’azzardo spesso è terrorizzato dal giudizio: “Cosa penseranno se lo scoprono?”, “Mi considereranno irresponsabile?”, “Mi toglieranno i figli?”, “Perderò il lavoro?”. Questo pensiero produce un senso profondo di vergogna che spinge a nascondere il problema, a mentire, a isolarsi, a fingere che tutto vada bene — anche quando si è sul punto di crollare. È una trappola silenziosa: più si nasconde il problema, più la dipendenza cresce, più aumenta la vergogna, e più ci si allontana dalla possibilità concreta di chiedere aiuto.
La vergogna dei familiari: colpa, silenzi e paura
Non sono solo le persone che giocano a sentirsi intrappolate dalla vergogna. Anche i loro familiari, spesso, vivono sensi di colpa profondissimi. “Dove ho sbagliato?”, “Non mi sono accorta di nulla, è colpa mia?”, “Che madre/padre/compagna sono, se non ho saputo aiutarlo?”. Oppure: “Se lo dico a qualcuno penseranno che siamo una famiglia disfunzionale”, “Ho paura che ci giudichino tutti”.
È un dolore che si consuma nell’ombra e nella solitudine, spesso senza supporto e senza rete, soprattutto se mancano spazi neutri in cui parlarne senza essere colpevolizzati, dove le famiglie possano sentirsi accolte, comprese, non accusate o zittite.
Quando lo stigma sociale diventa un ostacolo alla cura
Il vero problema non è solo il dolore emotivo. È il fatto che lo stigma e la vergogna hanno effetti reali, tangibili, che incidono sul decorso della dipendenza e sulle possibilità di cura.
- Molti non chiedono aiuto per anni, anche quando la situazione è gravissima, per paura di essere giudicati, emarginati, etichettati.
- Questo ritardo porta a un peggioramento del problema: più gioco, più debiti, più menzogne, più fratture nelle relazioni.
- Il senso di colpa e l’autocolpevolizzazione possono trasformarsi in depressione, isolamento sociale, ansia grave, portando anche a gesti estremi.
- I familiari, paralizzati dal silenzio e dallo stigma, non riescono a intervenire, o lo fanno quando ormai il danno è profondo.
Uno studio condotto in Australia e pubblicato sul Journal of Gambling Studies mostra come il gioco problematico, pur essendo considerato da molti una condizione “recuperabile”, sia ancora associato — nella percezione pubblica — a difetti caratteriali, pericolosità sociale e scarsa probabilità di guarigione. In pratica: se sei un giocatore, sei debole, forse violento, e difficilmente cambierai. È questa immagine che si deposita nella testa delle persone. Ed è da questa immagine che le persone fuggono, evitando di parlarne, per non essere identificate con quello stereotipo.
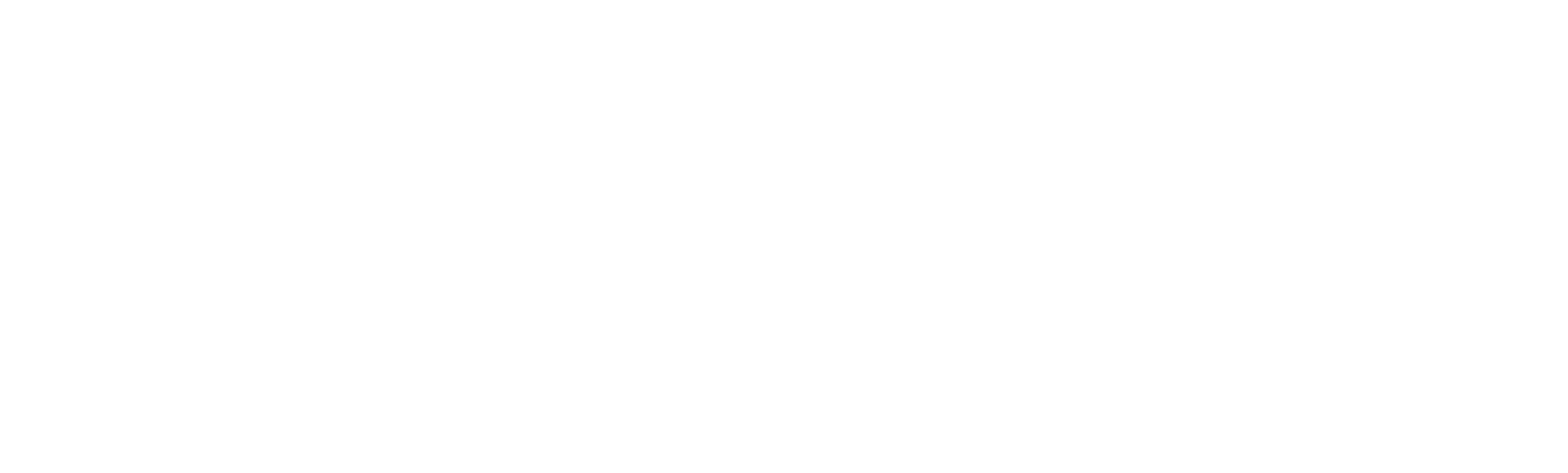


0 commenti