Quando una persona cara soffre di gioco d’azzardo patologico, è naturale sentirsi confusi, impotenti o pieni di domande: Come comportarsi? Che cosa dire (o non dire)? Dove cercare aiuto, e come capire se è davvero un problema di azzardo? Ecco le domande più frequenti che i familiari pongono ai gruppi di supporto che sono spazi di ascolto, senza giudizio, per orientarsi e iniziare un percorso di consapevolezza. Perché il cambiamento inizia anche da chi sta accanto. Perché la dipendenza da azzardo non è una colpa, non è una debolezza di carattere, non è qualcosa che “passa da sola”. Spesso chi sta vicino al giocatore nota prima i segnali. Fidati delle tue sensazioni: se qualcosa ti sembra “non tornare”, probabilmente c’è un problema reale.
Parlarne in spazi sicuri, come un gruppo di supporto, è un primo passo fondamentale.
1. Come faccio a capire se il mio familiare ha davvero un problema di azzado o sta solo esagerando un po’?
Spesso la linea tra gioco ricreativo e gioco problematico non è così evidente. I segnali più comuni includono: bugie ripetute sul tempo di gioco o sui soldi spesi, umore instabile dopo aver giocato, richieste di denaro improvvise, isolamento, irritabilità. Se il gioco sta influenzando negativamente la vita quotidiana, le relazioni, o le finanze, è importante non sottovalutare la situazione.
2. È colpa mia? Dove ho sbagliato?
No, non è colpa tua. La dipendenza da azzardo è una malattia complessa, legata a una molteplicità di fattori: psicologici, neurobiologici, ambientali. I familiari non sono la causa della dipendenza, anche se possono (inconsapevolmente) contribuire al mantenimento di certe dinamiche. Il senso di colpa è comune, ma non aiuta: è molto più utile concentrarsi su come affrontare la situazione nell’immediato.
3. Dovrei smettere di prestargli/le soldi? Mi sento in colpa a dire di no.
Offrire denaro in un contesto di dipendenza può, purtroppo, rinforzare il problema, anche se nasce da buone intenzioni. È difficile, ma stabilire limiti chiari è spesso necessario. È utile farsi accompagnare in questo passaggio da un gruppo o da un professionista che ti aiuti a reggere l’inevitabile pressione emotiva.
4. Come posso aiutarlo/a senza peggiorare le cose?
La cosa più importante è non sostituirti a lui/lei nel risolvere il problema, ma non lasciarlo/a solo/a. Puoi aiutare parlando con sincerità, evitando il giudizio, proponendo un confronto e — se possibile — indicando la strada per un supporto professionale. La chiave è: essere presenti, ma non complici.
5. Come reagire quando nega di avere un problema?
La negazione fa parte del meccanismo della dipendenza. Può essere frustrante, ma l’obiettivo non è “convincere” a tutti i costi. Prova a raccontare come ti senti, senza accusare. Usa frasi come: “Quando giochi, io mi sento…”, piuttosto che “Tu sbagli sempre…”. In alcuni casi serve tempo prima che la persona sia pronta a riconoscere il problema.
6. Il nostro rapporto è in crisi: posso occuparmi della dipendenza senza distruggere la nostra relazione?
Purtroppo, la relazione spesso è già compromessa dall’azzardo. Ma affrontare la dipendenza può essere anche un’occasione di verità. L’importante è proteggere te stesso/a: anche tu hai diritto a cura, rispetto, ascolto. Il percorso di supporto serve anche a questo.
7. Esistono percorsi di supporto per i familiari? Devo partecipare anche se lui/lei non vuole farsi aiutare?
Sì. Esistono percorsi dedicati solo ai familiari, come gruppi di auto-mutuo-aiuto (es. Gam-Anon di Giocatori Anonimi) o sportelli nei Ser.D o il nostro servizio in collaborazione con Vinciamo il Gioco. Tutti gratuiti. Partecipare può essere utile anche se la persona con dipendenza rifiuta l’aiuto: ti aiuta a capire la situazione, a tutelarti e a non sentirti solo/a.
8. È vero che il disturbo da gioco d’azzardo è una malattia? Non è solo questione di volontà?
È vero. È riconosciuto dall’OMS come una patologia del comportamento, simile ad altre dipendenze. Non ha a che fare con la “debolezza di carattere”. Pensare che sia solo questione di volontà è una semplificazione dannosa che alimenta lo stigma e ritarda l’accesso alle cure.
9. Come faccio a parlare di tutto questo con i nostri figli?
Con parole semplici e adatte alla loro età, senza mentire, ma senza caricarli di colpa o paura. Puoi dire, ad esempio: “Papà/mamma ha un problema con il gioco, e si sta cercando di risolverlo. Non è colpa tua. Se ti senti preoccupato o hai domande, puoi parlarne con me.” Anche i bambini meritano di essere protetti con onestà e amore.
10. Posso davvero fare la differenza?
Sì. Anche se non puoi “salvare” qualcuno contro la sua volontà, puoi essere una presenza che sostiene il cambiamento, che resiste allo scoraggiamento, che trova il coraggio di chiedere aiuto per sé e per chi ami. E questo è già moltissimo.
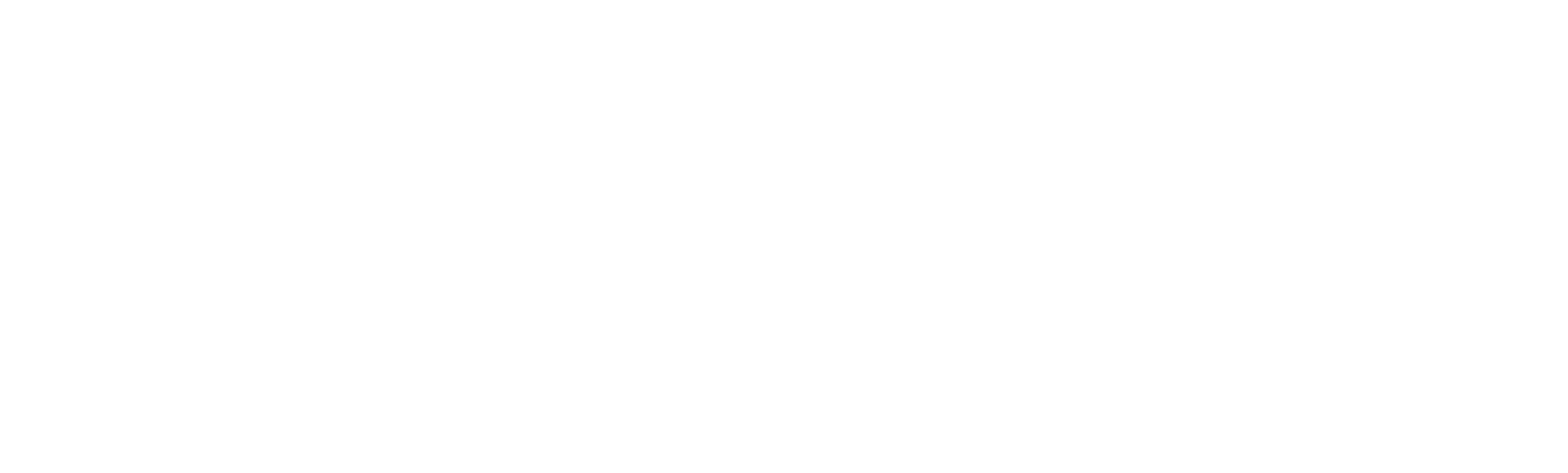

0 commenti